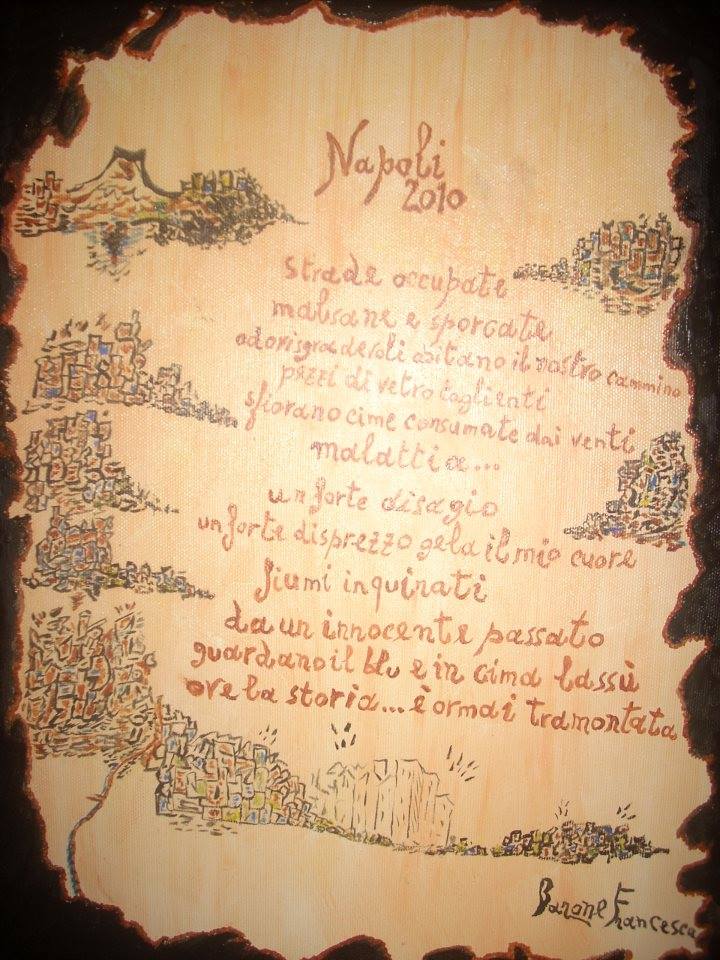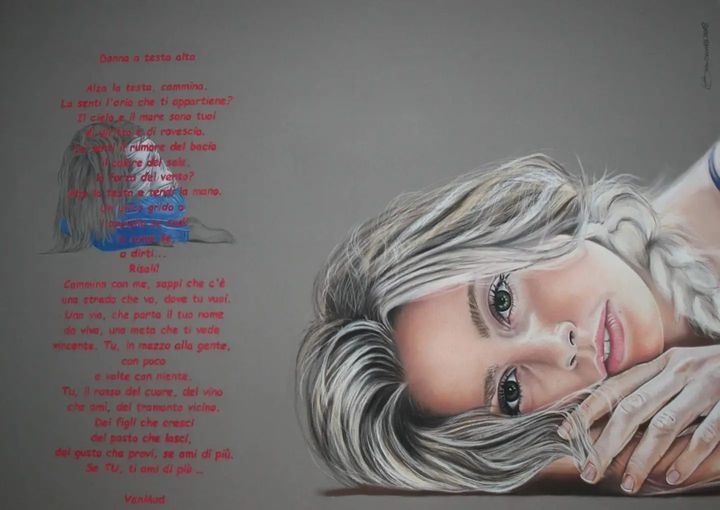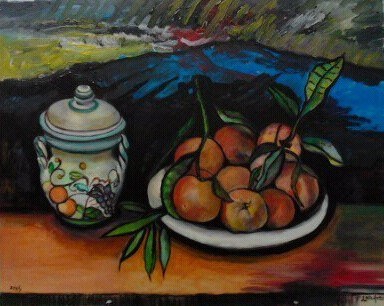Il Natale dell’angelo dimenticato
di Giovanna Esse
Dio ci ha donato la memoria, così possiamo avere le rose anche a dicembre.
Uno
Aprii gli occhi lentamente.
Il fuoco crepitante nel caminetto danzava veloce emanando un piacevole tepore.
Tirai un respiro profondo e mi decisi a mettermi in piedi.
Raccolsi dal tavolino il libro e lo snifter che conteneva ancora gran parte del pregiato Cognac che mi ero regalata… una piccola trasgressione da single che lavora. Poi salii le scale per raggiungere la zona notte.
Lilith, acciambellata sul pianerottolo, si riscosse per fissarmi coi suoi occhioni; si stiracchiò e, mentre mi avvicinavo, si mise in piedi srotolando la schiena, pronta a ricevere la carezza che le spettava.
Fuori, la notte, scura come la pece, era costellata soltanto dalle luci fioche dei radi lampioni, mentre la neve continuava a scendere, fitta e silenziosa, vestendo di bianco ogni centimetro di terra. Distante, un alone indistinto e lieve delimitava i bordi della città.
Sulla destra, tra i tetti bassi delle villette, svettava la parte superiore del grande albero di Natale, addobbato per la festa sul sagrato, davanti alla Chiesa.
Staccando lo sguardo da quella specie di cartolina notturna, ricordai che, tanto tempo prima, dicembre era il mio mese preferito: A dicembre si festeggiava il Natale ma pure il mio compleanno! Era un periodo speciale, ricevevo regali, giocattoli e tanta attenzione; ero felice. Certo, in maniera infantile, come capita quasi sempre ai bambini o, perlomeno, ai bambini fortunati.
Col tempo, però, il Natale, come tutte le feste, aveva perso quel fascino; amavo ancora le feste ma per motivi più opportunistici.
Natale, uguale: qualche giorno di ferie, un po’ di pace, la fuga dal ritmo incalzante del mio lavoro… di grande soddisfazione ma anche estremamente impegnativo.
Insomma, il momento buono per staccare la spina.
Via il cellulare e… divano “a volontà”. Qualche buon libro, comprato mesi prima e tenuto da parte, giusto per gustarselo in santa pace.
Totale relax e una spietata selezione: contatti “zero” con coloro che, per tutto l’anno, fanno a gara per rompere le scatole.
Ero ancora sull’ingresso della camera, persa nei miei pensieri, quando un bussare sommesso mi riportò alla realtà; proveniva dal piano di sotto.
“Forse è solo il vento che spinge un ramo sulle finestre di legno” pensai, ma dopo pochi istanti i colpi si fecero sentire, lievemente più decisi. Ero molto perplessa, era tardissimo e non aspettavo nessuno.
Chi diavolo va in giro la notte di Natale bussando alle porte, invece di suonare il campanello elettrico?
Qualche amico che aveva rinunciato ai piaceri del cenone, per venire a bussare alla mia porta? Decisamente improbabile.
Nuovamente e chiaramente, nuovi e lievi colpi, stavolta inconfondibili.
Mi decisi e, controvoglia, ridiscesi le scale.
Il bambino sembrava sconcertato, immobile sulla soglia tremava intirizzito. Mi guardava dal basso; un soldo di cacio con gli occhi sgranati che sembravano chiedere tutto, mentre la sua bocca non diceva niente.
Ero sorpresa, certo; però avrei potuto capire, essere più pronta! Invece, me ne restavo immobile, impietrita, osservando lui e quel suo strano “vestito”…
Vestito?
No che non lo era!
Nell’insieme era tutto talmente assurdo che non riuscivo proprio ad accettare quell’inattesa presenza. Non perché un bambino sconosciuto mi si presentava alla porta a tarda sera; e nemmeno perché quella era la sera di Natale… Neppure perché aveva, stranamente, qualcosa di familiare negli occhioni scuri: no, ero sgomenta a causa della busta!
Insomma, il bambino era nudo.
Peggio, era malamente coperto da un sacchetto di plastica bianca, come quelli della spesa, solo un po’ più spesso. La sua testolina, con i capelli arruffati color tabacco, bagnati dalla neve fresca, spuntava da uno strappo grossolano, insieme a una delle piccole spalle da angioletto.
I piedini erano nudi e violacei dal gelo e io, dopo un lungo smarrimento, cominciai a darmi dell’idiota; della testa vuota!
Mi ripresi dallo choc e, senza perdere più un secondo, incurante delle possibili conseguenze, e pure pronta ad affrontare qualunque tranello da zingari, lo afferrai per le braccia e lo tirai dentro. In casa, al caldo.
Corsi all’impazzata per le scale e recuperai un plaid scozzese di morbida lana; poi raccattai un grosso telo di spugna, dal bagno, e quindi tornai da lui.
Lo ritrovai, dove lo avevo lasciato: seduto, sperduto, al centro del divano. Sembrava un piccolo principe che aveva appena perso il suo regno.
Per prima cosa, strappai via quella busta orrenda: non la potevo vedere! Quel sacco di plastica squallido, bagnato, mi stringeva il cuore fino a soffocarne i battiti, senza nessuna pietà.
Lo frizionai col telo, poi lo avvolsi teneramente nel plaid e continuai a cercare di asciugargli i capelli, ma niente… nonostante i miei sforzi, lui restava sempre umido.
Io non ero mai stata veramente mamma. Certo avevo cambiato pannolini; avevo giocato con i figli delle amiche, coi nipoti; occasionalmente avevo persino fatto da babysitter, ma non avevo mai avuto, tutta su di me, la responsabilità di un bambino. Cosa fare? Intanto quello continuava a bagnarsi!
Eliminata la busta, continuavo ad asciugarlo delicatamente e ora lo tenevo al coperto, sul grande divano.
L’appartamento era riscaldato e lui non tremava più tanto.
Ero quasi certa che stesse bene ma proprio non riuscivo a togliermi di dosso la trepidazione, la preoccupazione di accudire a un bambino. Anche se solo per una notte, sarei riuscita a farcela da sola?
Ah, che sciocca!
Ecco cosa ci voleva. Un bel bagno caldo. Come avevo fatto a non pensarci prima?
Qualunque mamma avrebbe subito capito che il toccasana era il bagnetto, come si fa ogni volta che i bambini tornano a casa, imbrattati e sudati, dopo…
Dopo cosa?
Da dove veniva quel ragazzino silenzioso, con gli occhi dall’espressione triste?
Per nulla al mondo avrei voluto metterlo a disagio, il “mio angioletto”, ma i suoi occhi erano strani; sembrava sano e aveva una bella pelle rosea, adesso, tenera e “lievitata” al tatto, eppure mi sembrava di guardare una persona adulta: occhi profondi, cupi, pieni di saggezza.
Bando alle ciance!
«Tutti in bagno!» strillai da sola nel grande soggiorno, tanto forte da sorprendere anche me. Aiutai il piccolo a mettersi in piedi; con disinvoltura lo presi a cavalcioni e, con lui sulle spalle, salii allegramente le scale, al canto fanfaresco dei famosi sette nani:
«Andiam, andiam, andiamo a far il bagno; ta tà, ta tà…»
Stavo impazzendo?
Decisamente sì.
Macchissenefrega!
Nemmeno ricordavo più l’ultima volta in cui ero stata veramente felice. Di quel gioire festoso, senza criticità, senza misura… come una bambina gioca con la bambola, sicura di tenere tra le braccia la più famosa tra le principesse.
La gatta era di sopra, forse gelosa dell’intruso rizzò il pelo, ostile, e se ne scappò via, annaspando e scivolando con le zampe sul parquet liscio, assumendo quell’andatura divertente che solo una gatta un po’ obesa può mimare.
Il bagnetto non fu tragico come immaginavo.
Solo alla prima vasca, una pipì era schizzata nell’acqua trasparente, cogliendomi di sorpresa. Colpa mia, avrei dovuto pensarci prima.
Mi godetti quel piccino come fosse mio.
Per fortuna non era una femminuccia, altrimenti le coccole e la toelettatura sarebbero durate perlomeno il doppio, ma lui, Angelo (lo avevo ribattezzato così) era un vero maschione, con tanto di pisello prepotente e tutto il resto in piena regola.
Com’era dolce stringerlo al petto mentre lo asciugavo, usai il mio accappatoio pulito, fresco di bucato.
Guardai l’ora, per abitudine. Strano, ero sicura fosse molto più tardi.
Passai altro tempo cercando di capire se fosse muto o non volesse parlare; poi, finalmente, cercai di contattare la polizia, il Telefono Azzurro… ma, forse per la nevicata che proseguiva incessante, il telefono non funzionava e, misteri della tecnologia, neppure il cellulare riusciva a connettersi.
Ci avrei pensato poi.
Adesso avevo tante cose da fare per il mio Angelo.
Provai a farlo mangiare, niente, non aprì bocca e nemmeno voleva bere: né il latte, e neppure l’acqua. Allora mi domandai da dove venisse fuori tutto quel sudore. La pelle del bambino continuava, impercettibilmente, a inumidirsi.
Il plaid non risolveva. Adoperai la termocoperta. Il piccolo, docile e tranquillo, si lasciava governare e non si lamentava mai per le “ristrutturazioni” che tentavo sul suo giaciglio improvvisato.
Tremando per l’emozione, e sentendomi del tutto inadeguata, quasi giudicata, misi in pratica un’idea, che da più di un’ora scacciavo dalla testa.
Con metodo, e senza pensarci più, mi spogliai, e mi preparai per andare a dormire; indossai un pigiama di cotone finissimo, nuovo e bianco e poi, decisa, montai sull’ampio divano, sotto la coperta, abbracciando stretto stretto il mio piccolo ospite.
Lo sapevo: Angelo, chissà dove, aveva una mamma e magari era anche in pena, ma per stanotte l’avrei protetto io. Per una misteriosa serie di eventi il piccolo era a casa mia e me lo sarei tenuto sul petto, come se fosse figlio mio.
Intanto, il mio gesto sconsiderato ottenne i risultati sperati. Come un cucciolo, Angelo si sciolse dal suo pacato immobilismo; tra le mie braccia, quel piccolo dall’espressione saggia, si adagiò e ridivenne bambino.
Si stringeva a me e spingeva, si voltava e rivoltava, sgomitando. Avevo la netta sensazione, mai provata prima, che volesse entrarmi dentro, pelle nella pelle, carne nella carne.
Dopo pochi minuti chiuse gli occhi dolcemente e, quieto, si addormentò circondandomi col braccino.
In pace, appagata e serena, finalmente, dopo qualche minuto, anch’io mi appisolai.
Due
Ero io!
La ragazzina nel bagno ero io… e avevo da poco compiuto sedici anni.
Vivevo a casa di mio padre, i miei avevano divorziato da tempo.
Avevo deciso di farlo lì, per la seconda volta, il test, per essere certa della mia rovina. Allora vedevo la mia situazione come una disgrazia insormontabile: ero piccola e tremendamente spaventata.
Mia mamma mi avrebbe letto tutto in faccia, ne ero certa. Già da qualche giorno la vedevo più apprensiva nei miei confronti.
Mi avevano detto che gli uomini certe cose non le sanno vedere. Speravo fosse veramente così, speravo che papà non si accorgesse di come stavo male.
Ero incinta!
E nella testa mi vorticavano mille pensieri. Giravano veloci e colorati come le tessere di una Slot Machine; per qualche secondo si fermavano nelle combinazioni più incredibili: scene del passato, del presente e dei possibili futuri; si bloccavano davanti ai miei occhi, come un fermo immagine da cartone animato. Non c’era il tempo di concepire uno scenario e approfondirne le conseguenze, che le carte ricominciavano a girare all’impazzata, confondendo le immagini, i colori del mio destino.
L’idea che avevo avuto riguardo al ragazzo che mi aveva presa, era rimasta nuda.
Il “cavaliere di fantasia” che mi ero creato, aveva perso ogni attendibilità e si era sciolto, come plastica bruciata. Adesso riuscivo a vederlo come lo vedeva mio padre: un moccioso insicuro e viziato… una nullità.
Quello che avevo creduto amore aveva perso consistenza quando gli avevo accennato la notizia. Ora che ero certa del mio dramma, il sentimento inventato crollò, e lui uscì definitivamente dalla mia esistenza.
Sapevo che sarebbe stato un problema mio e solo mio, e avevo una paura folle di chiedere aiuto.
Disperata, non sapevo cosa fare se non piangere a dirotto.
«Teresa, allora?! Vuoi uscire da questo cacchio di gabinetto? Stai bene?» Mio padre era dietro la porta, ma non potevo uscire in quello stato.
I giorni passarono.
Le pensai tutte e il suicidio in mare mi sembrò la soluzione meno dolorosa.
Oppure… far finta di niente? Impossibile.
Cercai suggerimenti sui giornali e sui libri, controllai persino la cronaca nera e ne rimasi raccapricciata. Leggere di neonati abbandonati nella spazzatura mi raggelava il sangue.
Però, la cosa che in venti giorni mi trasformò per sempre; che mi cambiò da ragazzina spensierata in donna disincantata e amareggiata, fu il pensiero che dentro la mia pancia cresceva un bambino: mio figlio. E invece io ero costretta a considerarlo una disgrazia.
Lui, piccolo, innocente, inconsapevole, indifeso.
Possibile che proprio il mio esserino avrebbe dovuto pagare per tutto il male, la stupidità, gli errori?
Poi, mio padre prese il controllo della situazione. E io mi adagiai nelle sue mani, vinta dalla mia incapacità di prendermi una responsabilità così grande.
Non ero pronta, lui lo sapeva, credo… o forse non sapeva proprio niente. Ma non lo giudico per questo. So che, dal suo punto di vista, agì per il mio bene.
Tre
Mi riscossi.
La notte era placida. Il manto di neve, adesso, regalava alla via un magico senso di pace e candore. Eppure pensai, chissà perché, che poteva essere una candida trappola. Come una chimera, quell’immagine incantata e pura, ammiccante, poteva uccidere in poche ore chi, in una notte come quella, si fosse ritrovato fuori, nel freddo polare.
Angelo dormiva tranquillo, sempre sudato, ma stava bene.
L’orologio doveva essersi fermato. La gatta si era raggomitolata sulle scale, rispettosa; aveva preso le distanze da quel mio intimo momento.
I gatti, che animali incredibili.
Era ancora notte fonda.
Non mi restava che sdraiarmi di nuovo vicino allo strano bambino, quello capitato per caso, o per fortuna, davanti alla mia porta, la notte di Natale.
Sorrisi a me stessa ma mi rammaricai che il piccolo non avesse mangiato niente.
La vigilia di Natale è un sacrilegio non mangiare… persino i più poveri trovano qualcosa, un posto per riposare e per mettere un boccone sotto i denti.
La vigilia di Natale solo i morti non mangiano niente! A quel brutto pensiero un brivido gelato mi attraversò la schiena.
Ma, la mattina dopo, il mio Angelo avrebbe consumato una colazione da re! A costo di infilargli il cucchiaio in bocca di prepotenza.
E poi avrebbe ricevuto un regalo.
No, quando mai? Molti regali, e solo giocattoli. Di quelli che non servono a niente ma sono colorati, luminosi, sonori.
Quei giocattoli con i segreti che solo un bambino può capire, nella semplicità della sua innocenza favolosa.
Tutto deciso.
Ero felice adesso e mi accoccolai di nuovo vicino a lui. Nel sonno ritornò a stringersi al mio petto, come attratto dalla calamita.
La mia vita di ragazza che sa tutto, volitiva e decisa, rovinò miseramente.
Diventai una specie di pupazzo che diceva grazie a tutti. Mi sentivo in obbligo con il mondo intero: con mio padre; con il suo amico dottore; col ginecologo che, con la faccia storta, mi accettò controvoglia. Con mia madre no. In qualche modo la ritenevo responsabile, forse per l’eccesso di fiducia che aveva riposta in me.
Ora che ero diventata improvvisamente un’adulta in un corpo da ragazzina, cominciavo a intuire che la sua indulgenza, e la libertà che mi lasciava, non era tanto un segno di fiducia, ma di egoismo e strafottenza.
Quella donna non era mai cresciuta e non aveva nessuna intenzione di farlo.
Capii di essere una degente quando mi ritrovai in pigiama, seduta su un lettino, mentre rispondevo a un uomo in camice bianco, falsamente gentile, che mi faceva strane domande su malattie che non ricordavo…
La sola parola “anestesia” sarebbe bastata per mandarmi in trance. Una variante subdola del mio egoismo, nascosta abilmente nel profondo, si manifestò all’improvviso: la paura di morire.
Una paura irrazionale ma incontrollabile, insensata e senza direzione. Era la parte di me che ormai ero fermamente decisa a ignorare. Come fosse un pezzo sbagliato, un enorme boccone indigesto… da espellere al più presto.
Lo rifiutavo, mi ero lasciata convincere ma capivo che stavo rinunciando a una parte di me, per sempre.
Non mi aspettavo di dover passare la notte in ospedale. Piansi. Pensai più volte di uscire, di fuggire, ma non ne ebbi la forza, né il coraggio.
Mezza addormentata, mi sentii scarrozzare nei corridoi; le luci bianche delle plafoniere di plastica, mi passavano sulla testa: mi pareva di percorrere un tunnel. Le persone, intorno, erano solo ombre indistinte e fugaci, voci che si perdevano nei corridoi.
Qualcuno mi teneva la mano; una donna mi parlò, ma non capii, e neppure volevo. Non m’importava più niente. Pensavo: forse è questo che provano i condannati a morte. Un distacco totale dal mondo, dalla vita, dal proprio stesso corpo…
Rumori strani di acciaio; cigolii, chiacchiere sommesse di voci sconosciute. Qualcuno mi faceva ancora domande ma non desiderava alcuna risposta.
“Perdono, perdono, perdono…”
La sola, semplice parola che mi tamburellava nella mente.
Era tutto buio e avrei potuto tranquillamente essere morta.
“Perdono… perdono…”.
Quattro
Accecata dalla luce intensa del giorno, mi risvegliai con un tamburo nella testa: la vita era così luminosa e violenta, quella mattina, che stentai a riprendere coscienza.
Ci misi qualche secondo a orientarmi, per quanto profondamente avevo dormito.
Ero sola e infreddolita nell’ampio salotto, così essenziale, così vuoto.
Il mio plaid era caduto mentre dormivo sul divano e… il bambino…
Il bambino!!!
Dov’era finito “Angelo”?
Mi riscossi di colpo, saltando in piedi. Scalza com’ero, mi precipitai in cucina, poi di sopra, poi nel bagno.
Niente!
Guardai nell’armadio, guardai persino sotto il letto e fuori dalla porta: ero disperata, ero sconvolta.
Che fine aveva fatto il bambino?
Dov’era, adesso, Angelo?
Cercai ancora poi mi decisi a chiamarlo, ad alta voce, a chiamarlo con quel nome che lui non poteva nemmeno conoscere:
«Angelo! Angelo.»
Fuori era mattina inoltrata. Il sole, specchiandosi sulla neve bianca, diffondeva una luce violenta.
Lontano, le campane delle chiese suonavano con una nota gaia nel rintocco.
Ero confusa, frastornata, non sapevo cosa pensare, cosa raccontare. A chi avrei potuto riferire la mia storia? Come potevo spiegare alla polizia che quella notte, con sette gradi sotto zero, un bambino sconosciuto e nudo, aveva bussato alla mia porta?
Nessuno mi avrebbe creduto.
Sedetti su una sedia, sconfortata e triste… mi sentivo stanca, improvvisamente svuotata. Cominciai a temere di essere stata vittima di un’allucinazione, di un sogno impossibile.
Non avevo fame.
La luce che entrava dalla finestra rendeva tutto più chiaro nella stanza.
Il camino era quasi del tutto spento.
Non sapevo proprio cosa fare, poi, il mio sguardo si posò sul divano, dove avevo passato la notte. Leggera, come l’impronta lasciata dal sudore, intravidi il segno di una sagoma: piccola, delicata, tenue. Aveva la forma precisa di un corpicino, piegato sul fianco, in posizione fetale.
Guardando attentamente, si distinguevano le gambette, trattenute verso il petto, la forma tonda della testolina e un segno che si apriva dalla spalla come un ventaglio. Forse era solo la traccia di una mano aperta, forse la mia.
Eppure ricordava vagamente la sagoma di una piccola ala.
Mi avvicinai per guardare meglio, per capire, per convincermi di non essere completamente pazza. Ma, mentre mi accostavo, l’impronta del bambino evaporò, scomparendo lentamente dalla mia vita.
Mi lanciai sui cuscini, affondando il viso nelle ultime tracce di quella scia soave, strisciando le palme sul divano, per non perderne nemmeno un alito.
Piansi a lungo, col viso sprofondato nel divano, irrorandolo di lacrime.
Quel giorno non risposi al telefono e non aprii la porta a nessuno. Me ne stetti tranquilla, senza pensare a niente, senza cercare di capire.
Alla sera telefonai soltanto a mio padre.
«Ciao» disse, «mi fa piacere sentirti.» Ascoltavo volentieri la sua voce, dopo tanto tempo, ma lo interruppi; avevo una cosa importante da dirgli.
«Volevo solo dirti che cambio lavoro. Buon Natale, papà.»
Il giorno dopo ero di nuovo in forma!
Alle poche chiamate risposi vaga, avevo la testa da tutt’altra parte. Mentre le mie, di chiamate, lasciarono stupiti i miei interlocutori.
Telefonai al mio capo, gli feci i miei auguri più sinceri, e poi gli comunicai le mie dimissioni. Rimase stupefatto, senza parole.
Poi toccò a Enrico, un amico che faceva volontariato alla Caritas. Fu molto gentile: sorpreso, se la prese un po’ per la mia insistenza.
«Tesoro, tutto quello che vuoi. Mi fa piacere… ma oggi è festa! Non posso portarti da nessuna parte. Lo capisci?»
«Allora domattina?»
«Va bene, domattina ci provo,» acconsentì suo malgrado, «dammi il tempo di fare qualche telefonata. Chiamami alle… alle undici, ok?»
«Ok!» risposi entusiasta «Alle undici. Sarò puntualissima.» sorrisi alla cornetta.
Il divano era tornato normale; restava solo la traccia scura di una scia di trucco. I miei occhi avevano versato molte lacrime, anche se dovevo aver sognato tutto.
Persino l’orologio aveva ripreso a funzionare.
Tutta la mia casa era tornata perfetta, efficiente, normale.
Sogno o non sogno, ero certa che, se da qualche parte esisteva davvero, il piccolo Angelo adesso stava bene. Ne ero certa; lo sentivo dentro!
E anch’io stavo bene. E la mia decisione era presa!
Per ingannare il tempo mi misi a fare un po’ di pulizie, soprattutto per riprendermi dagli eventi delle ultime ore; immaginazione o meno, mi avevano cambiata radicalmente.
In bagno, a terra, c’era ancora il mio accappatoio. Lo raccolsi con indifferenza e… trasalii arretrando, per poco non caddi, inciampando in uno sgabello.
Sotto l’accappatoio, i pezzi strappati di una spessa busta di plastica bianca.
Li raccolsi con le dita tremanti, su un lembo c’era una scritta sbiadita, che faticai a decifrare:
‘Ospedale Bambin Gesù. Rifiuti speciali organici — Tipo B.2.’
Caddi sullo sgabellino, senza forze. Poi raccolsi tutti i frammenti di plastica, li sistemai nell’accappatoio e lo ripiegai con la delicatezza della mano di mamma.
Cinque
Il mio mistero è rimasto chiuso in me, per sempre.
La mia decisione era già presa da prima. Il ritrovamento della busta nel mio bagno non la cambiò né la stimolò.
Il mio programma rimase invariato.
Il giorno dopo, alle quindici, come promesso, Enrico mi presentò a uno dei suoi amici più cari.
Era un uomo simpatico, aperto, dagli occhi vispi. Il coordinatore responsabile dell’UNICEF nella mia città.
«Quindi lei si offre per una missione a tempo pieno? Una scelta impegnativa,» disse squadrandomi per l’ennesima volta. Poi i suoi occhi tornarono sulla scrivania, guardò di nuovo i documenti che teneva tra le dita. «… una scelta repentina. Certo, col suo curriculum, per noi sarebbe una collaborazione preziosa…»
Ci guardò di nuovo, come cercasse conforto anche da Enrico, poi continuò con voce pacata, sorprendendomi per la sua saggezza.
«Non le chiedo da dove nasce questa sua decisione, spero solo che lei sia pronta ad affrontare una vita difficile e confido che la sua determinazione non venga meno proprio quando poi ce ne sarà più bisogno. Va bene, Teresa?»
«No, no» dissi con enfasi eccessiva «non succederà più!» poi mi morsi il labbro.
La mia gaffe non fu sottolineata dal mio interlocutore, e lo ammirai per questo.
«Dove preferirebbe andare? Ha qualche idea, qualche preferenza?»
«No, nessuna.» risposi con entusiasmo infantile «Mandatemi dove ci sono bambini, tutto qui. Al resto penserò io… io, e il mio Angelo custode!»
FINE
© – Giovanna Esse 2015 – 2022
https://giovannastory.altervista.org/